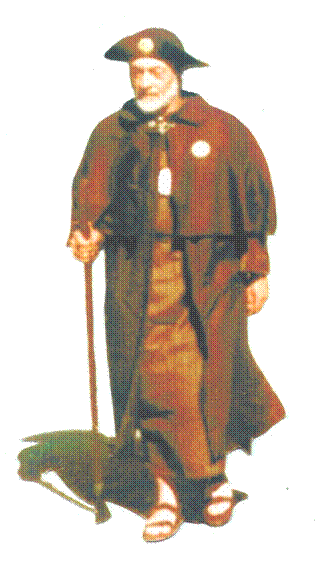
990.000
passi
seguendo orme
… profonde mille anni
da Roncisvalle a Santiago de Compostela
in 18 giorni
2 luglio
da Roncisvalle
a Pamplona
km 53,500
Non riesco a capire…
tutto è silenzio ovattato. Avverto un leggero, sottile e fastidioso senso di
disagio non riuscendo a mettere a fuoco la realtà, gli occhi non mi vengono in
aiuto a causa dell’impenetrabile oscurità che mi avvolge. In un gesto
automatico e spontaneo, la mano annaspa alla ricerca di qualche punto di
riferimento al quale aggrapparsi per aiutarmi a capire dove mi trovo.
Improvvisamente il freddo del metallo della branda a castello mi riporta
violentemente nel dormitorio della Collegiata.
Sono in cammino, anzi devo dare il via al mio
cammino. Pochi minuti per realizzare che sta per
iniziare l’avventura sognata per un anno intero. Pochi minuti sono sufficienti
per darmi la carica, per accendere quell’entusiasmo
che mi spinge ad alzarmi, quasi stia correndo il rischio di perdere non so
quale treno, visto che il treno che mi condurrà a Santiago sono solo i miei
piedi, supportati da quel paio di scarponcini che ormai, dopo gli intensi e
costanti allenamenti effettuati sui sentieri della Lombardia e del Piemonte,
sono quasi parte integrante di me.
Gli altri pellegrini stanno ancora dormendo
beatamente nelle loro brande; per non disturbare, raccatto alla bell’e meglio il sacco a pelo, lo zaino e gli scarponi e, a tentoni, mi avvio verso l’uscita del dormitorio. Una volta
nell’androne, mi vesto e dopo essermi posto sulle spalle lo zaino debitamente
assettato per il viaggio, inforco gli occhiali e lancio uno sguardo
all’orologio. Attimo di panico, di sgomento e di incredulità, sono le due! Le
due del mattino…
“E adesso cosa faccio?” Ormai sono sveglio, lavato
e vestito, armamento in spalla e cingolati
ai piedi, non mi sembra il caso per poche ore di ritornare in branda, anche
in considerazione del fatto che partendo adesso posso giocare sul tempo,
mettendo in cascina, come si dice da noi nella piana lombarda, un po’ di
chilometri in abbuono sulla tabella di marcia.
Confidando nella buona sorte, ripercorro i
corridoi della sera prima, scendo le scale, sperando di riuscire, una volta giunto al
portone, a trovare la maniera per poter uscire e non trovarmi costretto
ad aspettare il risveglio dei custodi della Collegiata.
Mi sorprende, scendendo
la scalinata, il garrire e lo svolazzare di molte rondini, probabilmente
disturbate dal mio passaggio, visto che hanno scelto, per la costruzione dei
loro nidi, proprio l’androne di questa secolare scalinata e, probabilmente, non
è loro abitudine veder transitare a quest’ora, pellegrini insonni o troppo
ansiosi di intraprendere il cammino.
Con un certo senso di
colpa per averle disturbate, mi sorprendo a chiedere scusa, ad augurare una
buona giornata e a chiedere un augurio di buon cammino.
“Sto parlando alle
rondini! Che il cammino stia già manifestando i suoi effetti deleteri? Che
stia, prima ancora di incominciare, a dare i numeri?” No, è senza dubbio
l’entusiasmo a mettermi di buon umore e mi predispone ad essere positivo verso
il creato, a cercare di cogliere il meglio di quello che la giornata, da adesso
e per tanti giorni, mi riserverà.
Mi sento euforico, saluto
le rondini e, non senza fatica, faccio scorrere l’enorme catenaccio; una volta
aperto il pesante battente consunto dal tempo, mi affaccio sul buio della
notte, ancora profonda, lasciandomi alle spalle un portone che mi sembra sia il
valico tra il sogno e la realtà.
Quasi senza aver avuto
alcun comando, le gambe mi si muovono verso il buio che, dopo i sei o sette
lampioni che costeggiano l’ingresso alla Collegiata, con perentoria autorità la
fa da padrone.
Sto camminando in
un’oscurità pressoché totale. Di tanto in tanto lancio qualche colpo di torcia
elettrica per vedere cosa mi riservano i prossimi metri, più per prudenza che
per necessità, infatti il cammino procede sul bordo
della carretera, quindi la possibilità di smarrirmi è
alquanto remota.
Il silenzio, che
all’inizio mi sembrava assoluto, di passo in passo si fa sempre più sottile;
avverto in lontananza il belare di qualche pecora, dal bosco mi giunge il
gracchiare di uccelli, che nel mio immaginario identifico in cornacchie o
corvi. L’abbaiare di un cane in lontananza mi fa supporre che, malgrado l’apparente assenza di presenza umana, qualche
casolare in qualche posto al di là del bosco debba custodire il sonno di
qualcuno, ignaro del mio passare in questo momento sul Cammino di Santiago.
A fare da contraltare alle diverse voci della natura che mi seguono
quasi come una colonna sonora in costante sottofondo, per ore mi accompagna un
allegro gracidare di rane, ora intenso, proveniente, mi pare, dal fosso che
costeggia la carretera, ora più debole e lontano, ma
sempre insistente nella sua costanza quasi ossessiva.
Di tanto in tanto, il
bosco si ferma, quasi a concedersi un attimo di respiro, il chiarore della luna
piena s’impadronisce del paesaggio e l’atmosfera diventa subito magica.
Il cielo, tempestato di stelle come non ho mai
visto, si pavoneggia nel suo mantello blu intenso e l’atmosfera è talmente
limpida e tersa da darmi l’impressione che la miriade di stelle debba, da un momento all’altro, staccarsi dal cielo e
piombare sui prati e sui boschi della Navarra (ora
capisco, toccando con gli occhi, perché il Cammino venga anche chiamato “
In lontananza incomincio
a intravedere qualche luce: è il primo paese che trovo sul Cammino. Auritz mi accoglie silenzioso ed assonnato, lo attraverso
senza incontrare anima viva, soltanto un gatto grigio, accoccolato sul
davanzale di una finestra, al mio passare, apre gli occhi e mi osserva transitare,
probabilmente chiedendosi cosa ci faccia in giro alle tre del mattino un
qualcuno, un po’ strano con zaino sulle spalle e bastone in mano; ancora
caricato dal mio entusiasmo, lo saluto augurandogli il buongiorno, cosciente di
non essere sentito da nessuno e mi lascio i quattro lampioni accesi alle
spalle, inoltrandomi nuovamente nel buio della notte accompagnato dalla musica
della natura.
Ad Auritzberri
mi fermo sul sagrato della chiesetta, dove una fontanella ed una panchina mi
fanno compagnia nella prima sosta per un sorso d’acqua, cinque minuti di pausa
per consumare come colazione qualche cracker e per concedere un po’ di sollievo
alle spalle che già incominciano a lamentare il peso dello zaino.
“La ricreazione è finita”
mi dico, “In cammino, che ti aspetta l’Alto de Mezkiritz”.
Il comando quasi
perentorio che mi lancio, ha l’intento di esorcizzare quel sottile timore
dell’ignoto che so di dover affrontare. Fin qui il Cammino è stato in discesa, ora però, così mi dicono le guide che mi sono portato
appresso, mi aspetta l’ascesa ai
L’allenamento che ho
fatto è stato intenso ed accurato, ma esclusivamente in pianura. Ho messo nelle
gambe tanti chilometri, so perfettamente di essere in grado di affrontare ore
ed ore di cammino, ma solo ora mi appare concreta l’incognita del camminare in
salita.
Ho sempre sviato il
problema, ora invece non posso più scappare, l’ostacolo è lì, più avanti, lo
devo affrontare… quindi zaino in spalla… e via.
Il sentiero scorre tra
boschi talmente fitti che nemmeno la luna riesce a far filtrare alcun bagliore.
Il buio è assoluto, tanto che devo procedere quasi sempre con la pila accesa e,
stranamente, per circa un’ora cammino nel più assoluto silenzio.
Non mi accompagnano più il gracidare delle rane,
né il cinguettio degli uccellini o il lontano abbaiare dei cani, sembra di
essere entrati nel nulla, non vedo nulla, non sento niente, solo il ritmico
calpestio degli scarponi
sul sentiero e
il sommesso sciacquio dell’acqua della bottiglia che,
riempita ad Auritzberri, gorgheggia nello zaino.
A Biscarret,
la segnaletica del cammino mi porta su un sentiero che, col progredire diventa
sempre più irto, impervio e disastrato. Quando ormai mi assalgono, prima il
dubbio, poi la convinzione, infine la certezza di essermi perso, anche perché
da diverso tempo non scorgo più alcun segnale, mi appare improvvisamente, su un
tronco mezzo divorato dal tempo e consumato dalle intemperie, una freccia
gialla che mi indirizza verso un sentiero sulla sinistra, sentiero che in
assenza della provvidenziale freccia, il buon senso avrebbe senz’altro scartato
senza ombra di dubbio.
Fortunatamente sta incominciando
ad albeggiare, inizio a vedere per lo meno dove metto i piedi e tutt’intorno lentamente prende forma il territorio; riesco
a distinguere gli arbusti, i cespugli di erica che con i loro rosa e i loro
rossi rendono più vivo il palcoscenico sul quale sto recitando la mia
performance.
Ginepri, castagni,
qualche conifera, querce e acacie si alternano scortando i passi di chi, come
me ora, nel corso della storia ha bagnato col proprio sudore queste zolle e
questi sassi. Una luce rossa, di tanto in tanto sembra farmi l’occhiolino tra
le fronde. Dopo svariate supposizioni mi sembra di poterla identificare come la
cima di quello che penso sia un ripetitore; sembra indicarmi la via, si
avvicina sempre più e quando la raggiungo, mi accorgo finalmente che la salita
è finita, un alto traliccio metallico troneggia proprio sul valico del Mezkiritz.
Mi fermo qualche minuto,
lancio uno sguardo in direzione di Roncisvalle.
Dietro le alte vette
della catena Pirenaica, il cielo schiarisce, si tinge gradatamente di un tenue
rosa che lentamente passa al blu stemperandosi in un azzurro screziato da
bianchi cirri.
Il tutto mi annuncia che tra poco, da dietro quei
monti esploderà, in tutto il suo splendore, pronto ad accompagnarmi verso Pamplona, un sole caldo e luminoso.
L’euforia che mi pervade,
per aver terminato la fatica della salita, svanisce subito dopo pochi passi di
discesa! Il terreno diventa improvvisamente impervio, ripido e sconnesso,
sassoni enormi sembrano essere stati buttati a caso lungo quello che, con non
poca fantasia, continuo a ripetermi è il Cammino.
Mi sembra di camminare nel greto di un torrente, i
passi diventano sempre più difficoltosi nel tentativo di trovare un appoggio
sicuro e saldo ove porre i piedi che, tra le mille difficoltà, incominciano a
lamentare indolenzimento e qualche fitta: poco gradito segnale di incipienti
fiacche.
Improvvisamente, dopo un ennesimo dosso, tra le
fronde di un castagno secolare appare la sagoma di un vecchio campanile, tanto
quanto basta per farmi scordare quello che sta succedendo nei miei scarponi. Il
passo si fa più veloce, grazie anche ad un terreno che nel frattempo si è fatto
più camminabile.
Dopo circa dieci minuti, faccio il mio ingresso in
un paesino: qualche stalla, poche case piuttosto scalcinate, la chiesa che con
il suo campanile, alquanto malandato, sembra essere più grande di tutto il
borgo stesso, sproporzione che mi appare curiosa e singolare.
Scoprirò in seguito come questa curiosità sia quasi la norma lungo il magico territorio che corre dai
piedi dei Pirenei fino alle aspre scogliere con cui
Si tratta di insediamenti religiosi sorti come chiese-fattoria,
all’ombra delle quali poi si sono sviluppati gli agglomerati abitativi,
trasformatisi successivamente in piccoli borghi.
Percorro l’unica strada che attraversa l’abitato
di Erro, strada rigorosamente in terra battuta. Rivoli di liquame sgorgano
dalle stalle che costeggiano la via e si perdono dopo pochi metri, bevuti
dall’arido e polveroso terreno. Il paese mi accoglie con una desolata
solitudine, non incontro anima viva, solo il grugnire di qualche maiale e lo
scampanio di campanacci che mi giungono da dietro la chiesa denunciano una
qualche forma di vita.
Una fonte, sul retro del
campanile, disperde in strada il povero rivolo d’acqua zampillante da un tubo
metallico che fa capolino dalle pietre di un disastrato muretto; una pietra
posta mo’ di panchina, mi invita ad una sosta, suggerimento che accetto senza
farmi pregare.
Il primo sollievo va a beneficio delle
spalle che alleggerisco dal peso dello zaino, poi tolti gli scarponi, la
frescura dello zampillo, poco nella quantità, ma infinito nell’effetto, riesce
a resuscitare e a riportare in vita un paio di piedi dei quali, solo ora, mi
rendo conto dell’importanza.
Due piedi che mi dovranno
portare fino a Santiago, due piedi che sono l’unico mezzo di trasporto su cui
potrò contare nel prosieguo della mia avventura... avventura o follia? ...
Scaccio subito il dubbio, in fondo sono solo al primo giorno di cammino e se
incomincio adesso a frignarmi addosso... Cosa ne è stato della determinazione
che mi ha sorretto durante un anno di preparativi?
Dove è finito il piglio
con il quale, salutata la mia famiglia all’aeroporto di Malpensa,
ho preso posto sulla poltrona del volo per
La sicurezza e la
baldanza con cui ho tentato di illustrare ad amici e conoscenti il significato,
lo scopo e le motivazioni di quanto mi accingevo a compiere, si sono forse
consumate sui sassi del sentiero percorso fin qui? No, non può essere così, non
deve essere così.
Il belato di una capra,
probabilmente assetata e stanca di aspettare lo scorrere delle mie elucubrazioni,
mi riporta al concreto dei piedi dolenti e dei tanti chilometri ancora da fare.
Mi sposto dal rivolo
d’acqua, frugo nello zaino alla ricerca di un paio di calzini puliti e di un
cerotto per la fiacca che mi si sta materializzando sul piede destro; la capra
soddisfa la sua sete, poi, dopo avermi lanciato un’occhiata che non capisco se
di rimprovero, di compatimento o cos’altro, si allontana trotterellando e
sparisce in direzione della freccia gialla che indica il cammino. “Che sia anche lei una pellegrina?” La domanda che pongo a me stesso, unico
essere umano nei dintorni, vuol quasi essere una battuta spiritosa per
sdrammatizzare il momento.
Con due spille da balia
assicuro allo zaino i calzini che ho lavato alla fonte, mi ricarico sulle
spalle il mio bagaglio, rifornisco d’acqua fresca la bottiglia della
sopravvivenza e via, passo dopo passo mi lascio scorrere sotto i piedi il
sentiero che, incominciando nuovamente a salire, mi avverte che mi sta
aspettando l’Alto de Erro.
L’ascesa, gradita
sorpresa, si rivela meno lunga e faticosa del previsto, per circa cinque
chilometri infatti, il cammino procede a lato della carretera e, quasi inaspettatamente, dopo una curva,
illuminato da un bel sole caldo, fa bella mostra di sé il cartello che recita
“ALTO DE ERRO mt.
Sull’ampio piazzale una
bacheca in legno, contrassegnata come punto de información turística,
descrive
Il panorama che si apre a
occidente, è molto armonioso ed invitante; una distesa di boschi, che sembra
scendere in un degradare dolce e sinuoso di alture ed avvallamenti, mi porta
già, con la fantasia, a Zubiri, prossimo paese che
secondo la mia guida dovrei incontrare.
Un cippo, con la
conchiglia gialla su sfondo blu e relativa freccia gialla, i simboli del
cammino, mi indicano il prosieguo del percorso. Una bella e fresca galleria,
formata da ombrose e verdi fronde di castagni
e betulle, scende dolcemente verso la valle, il sentiero in terra battuta e ghiaia è ampio
e ben tenuto, il sottobosco è ricco di svariati e variopinti fiori selvatici e
una gioiosa miscela di cinguettii e di frusciar di fronde accompagna il ritmico battere del bastone sul selciato.
Lo scenario che sto
attraversando, mi trasmette allegria, tanto che mi sorprendo non poco quando
tra le voci della natura circostante, individuo anche, fortunatamente
abbastanza sommesso, uno stonato canticchiare che non fatico a riconoscere come
mio.
Non è mai stata mia
abitudine il cantare, nemmeno durante la rasatura. Santiago mi sta cambiando
così profondamente? Se è così già fin d’ora, al primo giorno di cammino, mi
riconoscerò ancora una volta raggiunta la meta? Il susseguirsi di queste
riflessioni, si interrompe bruscamente contro un freddo cancello in acciaio che
improvvisamente sbarra la via. La sorpresa e lo stupore sono le prime
sensazioni che, dopo una attenta perlustrazione e la conseguente constatazione
d’impossibilità a proseguire, si trasformano in
disappunto.
La rete parte dal
cancello, corre sia a destra sia a sinistra, confondendosi con il bosco, con il
sottobosco e con quel senso di rabbia stizzosa che sento crescermi dentro.
Improvvisamente realizzo
che i circa due chilometri appena fatti in soave discesa, canticchiando
allegramente in felice beatitudine col mondo, si sono trasformati in
altrettanto percorso da rifare, ma questa volta in salita. Il disappunto tende
a trasformarsi in rabbia; mi sento preso in giro e non avendo sotto le grinfie
un concreto responsabile con cui prendermela, scarico la mia indignazione su
Santiago… “ San Giacomo, mi hai fatto un bello scherzo da prete! Non ti basta
il camminare che ho già fatto oggi?”
Lo sfogo ad alta voce,
con piglio quasi pronto alla lite, è sufficiente a far sbollire l’animosità che
mi ha suscitato quello che considero ancora un ingiusto dispetto.
Ripongo l’ascia di guerra “E va bene San
Giacomo, se è questo che vuoi da me, così sia.
Vorrà dire che hai le tue buone ragioni, perché mi rifiuto di
credere che ti possa divertire a far dispetti ai
pellegrini, ti considero troppo serio per ragazzate di questo genere!”
Rappacificato con
Santiago, con me stesso e col mondo, ritorno sui miei passi.
A scanso di ulteriori
sorprese, una volta riconquistata la carretera, mi
guardo bene dall’abbandonarla, anche se camminare sull’asfalto non è il massimo
cui possa aspirare, tuttavia la sicurezza di raggiungere Zubiri
senza altri intoppi diventa più importante della pur sempre valida poesia di un
romantico camminare tra i boschi.
Sono le undici e trenta.
Spingo la porta e, lanciando un buenos días entro nello stanzone di quello che il cartello
sull’uscio mi dice essere il rifugio del Ayuntamiento (Comune, Municipio)
di Zubiri.
Il buenos
días si perde tra due file di brande deserte e, dopo
aver rimbalzato su un gran tavolone in legno massiccio piuttosto consumato dal
tempo e sulle due lunghe panche che sembrano fargli da parentesi, mi precede
buttandosi sulla prima branda a tiro ed io lo imito senza indugio.
Rimando a dopo la
consultazione di alcuni dépliant che, sparpagliati sul tavolo, in maniera
apparentemente disordinata, sembra vogliano convincermi di essere giunto al
centro del mondo, della storia, della tradizione e chi più ne ha più ne metta.
Non mi pare mi sia mai
capitato di apprezzare con tanta intensità un giaciglio, né tanto meno di
gustare così profondamente l’atmosfera di un locale deserto e silenzioso.
“Dieci minuti di relax, poi mi faccio una doccia
prima di rimettermi in viaggio…” questo è quello che mi sembra mi stessi
dicendo prima di essere inghiottito dalla branda e digerito da un sonno tanto
profondo quanto improvviso.
Un vocío mi giunge da
lontano, non riesco a definirne la provenienza, mi arriva fievole e sottile, in
improvviso crescendo subito si smorza in quello che sembra solo il sussurro
della mia fantasia.
Lentamente svanisce quel
velo appannato sul vetro che separa il sonno dalla veglia, l’immaginario dal
reale. É forte lo sforzo per combattere la pigrizia che mi vuol immobilizzare
in branda, che mi si aggrappa alle palpebre, rendendole talmente pesanti da
impedirmi di sollevarle. Solo dopo diversi tentativi, aprendo gli occhi, vedo
un gruppetto di pellegrini che sta prendendo posto nel rifugio.
Lo sguardo che lancio
all’orologio mi dice che l’eternità che mi sembra d’aver dormito, è durata solo
poco più di un’ora, sufficiente però a ricaricarmi un po’ le batterie; una
breve, ma intensa doccia calda completa la ricarica.
Uscendo da Zubiri mi soffermo per qualche istante presso El Puente de
- il río Arga
è un torrente più ricco di sassi che di acqua -. Questo rito pare avesse la
facoltà di preservare il bestiame dall’ammalarsi di rabbia, specie da quella
suina.)
che scavalca il río Arga,
con le sue due arcate quasi completamente ricoperte d’edera pendente a guisa di
cotta e mi ricorda la bardatura di un cavallo di qualche paladino di Carlo
Magno. Guerriero che, perdutosi qui a Zubiri e
scampato alla disfatta che invece si è ingoiata Rolando con tutta la sua
armata, da allora indugia in questo luogo combattuto tra il desiderio di non
sottrarsi alla storia e il timore di giungere solitario ed in ritardo coi
tempi, all’appuntamento col suo destino.
“Quasi quasi scendo e mi faccio gli storici tre giri”. La
tentazione c’è, anche la suggestione del rituale preme, non sono però così
forti da distogliermi dal pensiero che la strada per Pamplona
è ancora lunga. Una fotografia, un ultimo sguardo al borgo vecchio e già il
ponte della rabbia mi svanisce alle spalle.

Ponte della Rabbia
Poco dopo l’abitato di Zubiri,
il paesaggio si ammala quasi improvvisamente. Il terreno, gli arbusti, tutto
intorno ha perso colore, un sottile velo impalpabile di polvere bianca ricopre
tutto quanto mi circonda. Velo di polvere che il passaggio di qualche auto, o
peggio dei tanti autocarri che vanno e vengono sulla statale, solleva
nascondendo tutto per qualche istante.
Diventa persino
difficoltoso respirare, tanto che devo proteggermi bocca e naso con un foulard,
come i cow-boys nel Far West.
L’interrogativo sulla
natura di questo attentato al territorio e al buon senso, trova presto una
risposta. Infatti, poco sotto il livello della strada, a ridosso del greto del río Arga, emergendo dalla nube
polverosa, incominciano a materializzarsi come fossero dei fantasmi, spettrali
capannoni, nastri trasportatori, arcigni tralicci e una quantità di cumuli di
materiale bianco e polveroso.
La rete che delimita
questo posto infernale, correndo a fianco della carretera,
di tanto in tanto si interrompe per lasciare il posto a cancelli rigorosamente
sbarrati.
Quando
raggiungo quello che deve essere l’ingresso principale, un cancello aperto
lascia intravedere una sbarra a strisce bianche e rosse ed un grande cartello
dal quale finalmente capisco che sto costeggiando gli impianti di una miniera
di magnesite.
Non so se
per la stanchezza, per il caldo di un sole martellante, per la bruttura della
miniera, o per la monotonia del tratto che sto macinando sotto gli scarponi,
sta di fatto che quasi non mi rendo conto di passare Larrasoaña.
Procedo ormai quasi senza interesse per il territorio che mi circonda, senza
più neanche il senso delle distanze o la percezione del tempo.
L’ormai
familiare freccia gialla mi consiglia di abbandonare la statale indicandomi una
stradina laterale che, sulla destra, si arrampica per poche decine di metri su
una brulla collinetta.
Passati Zabaldica
e Arleta, a Trinidad de Arre, con un caffè,
interrompo quella sorta di trance in cui mi sembra di essere sprofondato,
lasciandomi scivolare sotto i piedi la carretera N.
135 col suo traffico frenetico e chiassoso.
Gli spagnoli probabilmente non
comprano una automobile con il clacson, ma comprano un
clacson al quale è abbinata, in offerta speciale, un’automobile.
Il rifugio
del pellegrino, a ridosso della chiesetta della Trinità, è ancora chiuso.
Decido di non aspettare e rinunciando al sello, seguo senza oppormi i miei piedi
che autonomamente si sono rimessi in moto alla volta dell’ormai prossima Pamplona.
“IRUÑEA /
PAMPLONA” Cosa ci fa qui sul bordo della strada un bel quadro d’autore?
No, non è
un quadro d’autore, scherzo della fantasia in combutta con la stanchezza, è
solo il cartello segnaletico che accoglie chiunque entri in città.
Subito lo
squallore che caratterizza a quanto pare tutte le periferie, in qualsiasi parte
d’Europa, o forse del mondo, mi riporta alla realtà. Seguendo le indicazioni
per il “centro ciudad”, raggiungo la
parte storica.
Cattedrale
raccolgo il secondo sello per la mia credenziale e, dopo una breve visita alla
chiesa e all’attiguo stupendo chiostro gotico, volgo i miei passi verso il
vicino rifugio.
A sinistra
della facciata della Chiesa di San Saturnino, una decina di pellegrini, seduti
per terra, appoggiati agli zaini, mi fa capire di aver trovato il rifugio;
purtroppo non colgo il più sottile segnale che mi si paleserà tra breve.
Quando,
dopo tre piani di un’angusta scala, raggiungo con il fiatone una specie di
anticamera, anch’essa cosparsa di pellegrini sdraiati per terra o seduti su una
sedia, un calorifero, uno zaino, insomma qualsiasi cosa possa essere utile
all’uopo, mi sento dire che il rifugio è al completo, che non c’è più posto nemmeno
per un sacco a pelo sul pavimento: mi vien quasi da
piangere.
Inutili i tentativi, sia
miei, sia quelli più autoritari che due pellegrini tedeschi arrampicatisi con
me lungo i tre piani della stretta e ripida scala, praticano nel tentativo di
commuovere l’hospitalero. Nulla da
fare. Asseverare la credenziale con il sello del rifugio, più che volentieri,
ma il dormire qui “¡Nada, no está posible! “
La granitica
irremovibilità dell’hospitalero non vacilla nemmeno
di fronte alla minaccia del barbuto tedesco di mostrargli le sue dolenti ampollas (fiacche) ai piedi. Minaccia che per
lo meno viene gratificata di un paio di indirizzi di vicine pensioni ove poter
estendere la nostra ricerca di un letto per la notte.
La comune necessità
realizza istantaneamente l’Europa Unita! Insieme ci avviamo nella direzione che
tra derecha e izquierda
(destra e sinistra) ci sembra quella giusta ove cercare la prima pensione delle
due che ci sono state indicate.
Lungo la via, costeggiata
su entrambi i lati da sobri portici, si stanno già approntando le barricate
protettive per la settimana di festeggiamenti in onore di S. Firmino.
L’idea che proprio qui,
dove sto camminando adesso, tra qualche giorno e per una intera settimana
correrà una fiumana di fanatici spagnoli con fazzoletto rosso al collo,
inseguenti o inseguiti da tori infuriati, mi stuzzica la fantasia. “Però
sarebbe bello assistere alla festa, senz’altro deve essere una esperienza
emozionante. Se non avessi deciso di
essere a Santiago per i festeggiamenti del 24 luglio… no, proprio non c’è il
tempo.
Forse… l’anno prossimo…”
A questo punto quel
pizzico di raziocinio che ancora mi è rimasto, mi suggerisce che forse è più
saggio camminare in campagna e tra i boschi con uno zaino in spalla, piuttosto
che correre per queste strade cittadine, senza zaino, ma con il calore del
fiato di qualche toro sbuffante sul collo e magari la punta di qualche corno…
un brivido sottile mi corre lungo la schiena.
“Santiago aspettami, arrivo e ti prometto che
sarò puntuale alla tua festa, in fondo sei più importante
Tu di S. Firmino”.
La camera è spartana ma
pulita, essenziale e senza fronzoli, tre letti e due sedie; quattro assi
inchiodate e una tenda a nascondere tre grucce in fil
di ferro arrugginito, fanno l’armadio!
Né i due tedeschi né il
sottoscritto ci formalizziamo minimamente, l’unica cosa importante è l’aver
trovato un letto ciascuno. A questo punto mi appresto a celebrare quel rituale,
tanto piacevole quanto necessario, che d’ora innanzi sarà il quotidiano oggetto
dei miei desideri, lo scopo che mi darà, svegliandomi al mattino, lo stimolo e
la forza per affrontare le incognite della giornata: finalmente mi posso togliere
scarponi e calze, prima botta di goduria.
Salvietta in spalla,
bagnoschiuma in mano percorro il lungo e buio corridoio che si stende dormiente
tra la camera ove mi sono conquistato un
letto, “guai a chi me lo tocca!”, e la porta,
dietro la quale finalmente potrò concedermi la seconda goduria, una
quanto mai sospirata doccia, spero calda, visto che mi sento addosso, fra tutto
il resto, ancora la polvere della miniera di magnesite.
Una tortilla
di patate ed un buon bicchiere di vino rosso della Rioja
mi fanno compagnia, in realtà per poco, al tavolo di questo posto che, a dir la
verità, non ho ancora capito se è una pizzeria, un ristorante, una paninoteca,
un bar o non so che altro, poco importa, l’importante è che mi danno da
mangiare.
Qualunque cosa sia il
posto ove mi trovo, non sfugge a quella che ho già intuito essere un’abitudine
generalizzata in questa parte della Spagna: il pavimento è sommerso da ogni
genere di rifiuti, tovagliolini usati, mozziconi di sigarette, (impressionante
quanto fumino gli spagnoli) bicchieri di carta, carte di caramelle, gusci di
noccioline.
Insomma, di tutto e di
più !
Gli ultimi quattro passi della
giornata mi riportano in camera; non mi ricordo nemmeno se sono riuscito a
spegnere la luce o se, in un involontario gesto di cortesia, l’ho lasciata
accesa per i due tedeschi, probabilmente ancora alle prese con l’enorme
bistecca che ho visto loro nel piatto, sommersa da un mare di patatine fritte.